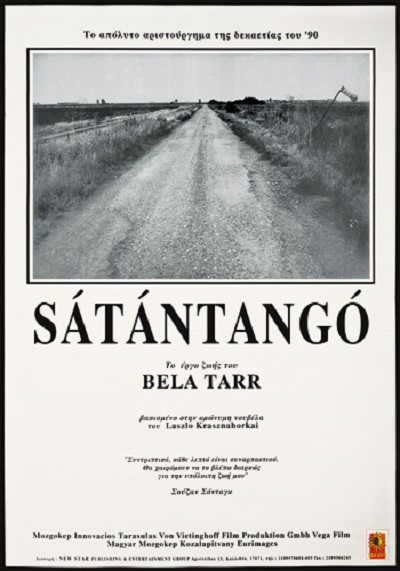Se il regista ungherese avesse saputo che il suo film sarebbe stato considerato, pressoché all'unanimità, come un'opera drammatica, probabilmente avrebbe insistito di più su alcuni concetti a lui cari, che pure aveva esternato ai tempi della presentazione del film, a Berlino. "Satantango" è alla fine una commedia umana di gigantesche proporzioni, la messa in scena polivalente di un'ipotesi paradossale: il tramonto dell'essere umano, la fine delle illusioni e delle speranze, l'annichilimento di fronte a forze soverchianti contro cui nulla si può opporre. Idealmente pensato, da Tarr e dal sodale scrittore László Krasznahorkai, come un canto finale del comunismo in Ungheria, con le macerie infinite lasciate fuori e dentro ciascun essere vivente, alla fine si è invece trasformato, durante i mesi di riprese, in una sorta di diabolica e purificatrice improvvisazione sul set, in cui l'autore ha sfidato i tempi del cinema e gli stili universalmente accettati. E tutto questo lo ha fatto per una battaglia finale, estrema, consapevole: sfida non solo al mezzo artistico stesso, ma anche al pubblico, alla Storia, alla mente umana. "Satantango" fa della sua durata, delle sue sequenze interminabili, della sua costante ricerca dell'anti-climax l'ossatura portante dell'opera medesima.
Una sfida lanciata a tutti noi
Questa collettività che rappresenta la fine di tutto non può essere ripresa e messa in scena con dei tempi canonici. Non può essere raccontata attraverso un montaggio e un'inquadratura ordinaria. L'abbrutimento generale, sconfinato e senza fine, non può che essere attraversato con la sofferenza di infinite scene, di lentissimi movimenti di macchina, di costanti ricerche delle parole fuori campo. Solo così la sensazione di un viaggio che conduce a una notte perenne può davvero dipanarsi negli occhi, nel cuore e nella mente di chi guarda. Sull'importanza dello sguardo varrà la pena ritornare.
A questo punto, occorre un'ulteriore considerazione. È vero, "Satantango" è stato un romanzo prima di un film. Ma il libro di Krasznahorkai è solo un punto di partenza, l'incipit per un lavoro di scrittura e, successivamente, di realizzazione scenica ben diverso. Non occorre fare un confronto meticoloso per evidenziare subito un elemento fondamentale: il "Satantango" cinematografico di Tarr è opera completamente diversa, fatta di moltissime cose in più. Le parole dello scrittore restano nelle descrizioni, in alcuni frasi pronunciate dal narratore esterno, nella struttura narrativa generale, ma poi il lungometraggio prende una sua forma viva e altra in totale autonomia e indipendenza. "Satantango" è "Satantango" perché Tarr usa la macchina da presa come solo lui avrebbe potuto, sceglie la dilatazione dei tempi e degli spazi fino allo spasimo, riflette attentamente sulla distinzione tra i carrelli laterali (che predominano) e quelli circolari (che avvolgono i protagonisti di alcune scene solo in determinati momenti di "rottura"). Siamo di fronte a uno degli esempi più dirompenti in assoluto in tutta la storia del cinema di un capolavoro che, rispettosamente, tradisce la fonte letteraria (un discorso simile, con le dovute distinzioni, si potrebbe fare per "Il lungo addio" di Robert Altman alle prese con il celeberrimo romanzo di Raymond Chandler).
Movimenti laterali, narrazione circolare
Il tango, come tradizione vuole, è un ballo codificato, tecnico, di nobiltà assoluta proprio perché si è dato delle regole e le vuole rispettare. Così il cinema di Tarr, apparentemente anarchico, provocatorio, improvvisato, ha il rigore formale e teorico che era stato di Andreij Tarkovskij. Sei capitoli in avanti, sei capitoli indientro nel filo cronologico degli eventi, proprio come i movimenti del ballo argentino. Le vicende di un capitolo si innestano su quelle degli altri attraverso poche inquadrature, alcuni cenni narrativi. La storia, in tutta la sua oscura angoscia, prende forma passo dopo passo. Dicevamo delle vacche che escono dalla stalla nell'incipit, l'inizio dell'ennesima giornata di attesa nella comune desolata e allo sbando. Il gruppo di persone che anima questo luogo sperduto nella pianura ungherese attende un momento imprecisato nel futuro: la fattoria verrà chiusa, con la caduta del regime, ci saranno i guadagni del duro lavoro da dividere e si potrà pensare di vivere il resto della propria esistenza altrove, magari dove il clima è più clemente. La vita qui scorre scandita dal ritmo e dal rumore della pioggia battente, del vento che spazza i boschi circostanti: non c'è nulla per cui valga davvero la pena alzarsi dal letto la mattina, se non il portare avanti gli istinti basici di un'esistenza privata di ogni sorta di interesse e aspirazione. Uomini e donne che, a forza di allevare animali e lavorare la terra hanno finito per vivere come animali assorbiti da quella stessa terra. E come animali, tutti hanno perso contatto con la dignità: le loro case fanno schifo, i loro vestiti sono ormai stracci, l'acqua con cui si lavano è quella piovana, non hanno più alcun tipo di rispetto per se stessi o per gli altri, tradiscono come niente, pensano solo ai soldi, al bere, soddisfacendo bisogni primari e carnali. Il mondo là fuori, preso da cambiamenti epocali, li ha dimenticati in questo angolo di Ungheria, li ha lasciati a lavorare convinti di un prossimo ingresso in una nuova era che, invece, è già il passato, altro che luminoso avvenire.
In tutto questo, si innesta il ritorno nel gruppo di un carismatico ex componente della comune, Irimias, uomo misterioso dato per morto da anni. D'intesa con le autorità, ma la vicenda è molto fumosa, ha il compito di liquidare quel gruppo alla periferia dell'impero, anche a costo di svilirne le ultime ambizioni. E così farà: dopo la morte della piccola Estike, il suo discorso, da grande affabulatore, provocherà nel gruppo la convinzione che la bambina, l'unica della fattoria, è morta per colpa di un po' tutti loro. Si farà dare tutti i loro risparmi con una vaga promessa di ricominciare in un luogo migliore. Ovviamente non sarà così. La piccola Estike è lo sguardo di chi invece grida il suo disagio e la sua sofferenza. È una presenza (e una assenza) fondamentale per carpire completamente il lento degrado del gruppo umano. Prima la vediamo guardare da fuori dentro la locanda dove gli adulti ballano completamente ubriachi, poi rivedremo la scena con la bimba al buio, i suoi occhi sbarrati oltre i vetri della finestra, a prospettive ribaltate.
La solitudine di Estike
Nella sua estenuante scena c'è forse il momento più doloroso di tutta la dolorosa via crucis di "Satantango": scopre di essere stata imbrogliata, chiede aiuto e non lo ottiene, scappa in solitudine, comincia a torturare un gatto fino a ucciderlo, infine ingerisce quel veleno per topi che ne causerà la morte. Estike è diversa dagli altri: nella sua infanzia è ancora custodita una vitalità, seppure folle e annebbiata dalla solitudine e dalla depressione, che poteva salvarla. Mentre le azioni e i comportamenti degli adulti sono meccanici, cadenzati da volgari e bieche abitudini quotidiane, Estike ancora conosce un movimento dinamico, corre, urla, si rotola nel fango. L'incomunicabilità fra lei e gli altri è la prova inversa di quanto questo plotoncino di uomini e donne ha ormai perso contatto con il mondo. Irimias avrà gioco facilissimo nel truffarli e abbandonarli al loro destino.
Tarr è un cineasta dalla profondità di sguardo incomparabile, almeno per quanto riguarda la produzione europea degli anni 90 e Duemila. Il rigore stilistico che ne caratterizza le opere, soprattutto quelle della sua folgorante fase della maturità, cominciata con "Perdizione" e giunta fino a "Il cavallo di Torino", gli permette di affrontare le sfide teoricamente più difficili con una relativa semplicità di esecuzione. La macchina da presa, l'uso delle maestranze tecniche e artistiche che lo supportano in fase di realizzazione, diventano veri e propri attrezzi di un mestiere artigianale. Artigianale sì, ma con alle spalle una tecnica e una consapevolezza filosofica della propria missione senza pari.
Il regno del piano sequenza, ovvero un'altra possibilità di volgere lo sguardo
Tre concetti chiave: piano sequenza, carrellata, fuori campo. La somma dei tre è l'essenza stessa di "Satantango". Sfidando la durata stessa della bobina di pellicola (circa dodici minuti), Tarr realizza un film di oltre sette ore fatto con circa 150 inquadrature. Il piano sequenza caratterizza tutta la seconda parte della sua carriera. A farne qualcosa di unico nel caso del capolavoro del '94 è il modo in cui si muove la sua macchina da presa all'interno dello spazio scenico. Quelle sue carrellate laterali che vanno a fermarsi su un punto morto, su un dettaglio degli ambienti, interni o esterni, apparentemente secondari nell'economia della scena, esaltano totalmente il ruolo da protagonista di ciò che circonda i personaggi: quel vuoto insulso è ciò che provoca quei dialoghi estenuanti, quella coazione a ripetere sempre gli stessi comportamenti. In questo si innesta poi il gusto per il grottesco, ereditato dalle opere giovanili. Non tutto deve avere una profonda spiegazione. Più semplicemente, a volte, Tarr, con il ghigno di chi riesce a tirare fuori dalle situazioni più improbabili momenti di paradossale umorismo, sposta l'occhio della sua cinepresa altrove per spiazzare colui che guarda. Mentre il dialogo tra i personaggi in scena prosegue fuori campo, il regista ci porta a guardare altrove, rilanciando la sua sfida all'attenzione, al saper discernere ciò che è rilevante da ciò che non lo sarà nel prosieguo della storia.
"Satantango" è una sfida continua, è un esercizio di visione cinematografica stupefacente e appagante, proprio per la soddisfazione che provoca in chi guarda. Quello sguardo dei protagonisti delle vicende, immortalato da fissi primi piani di lunghezza inusitata, è lo stesso dello spettatore dietro il grande schermo, "costretto" a riflettere su ogni singola scelta di regia. Costretto a interrogarsi sugli scarti narrativi e visivi che continuamente l'autore inserta nel film. Un esempio: l'impianto sonoro è generalmente dominato dagli elementi della natura, pioggia, vento, versi di animali. In poche occasioni, però, subentra, prepotente, il lirismo sfrenato della colonna sonora composta da Mihály Víg, fra l'altro colui che interpreta il protagonista Irimias. Nella carrellata circolare con la voce off che ci racconta i sogni che stanno vivendo nel sonno i personaggi, nell'arrivo alla nuova destinazione indicata dal falso profeta, la musica apre sul bianco e nero del direttore della fotografia Gábor Medvigy squarci di poesia e di speranza. È tutto vero? O è solo un trucco? Ciò che racconterà il dottore in un suo nuovo monologo solitario prima dei titoli di coda sta accadendo veramente nel futuro? O è solo un nuovo sguardo al passato? La scelta di Tarr è quella di "chiudere il cerchio" per l'appunto, con il nero che cala sulla scena.
L'importanza dello sguardo, che tiene vive le persone anche in mezzo al nulla interiore ed esterno, viene meno: il dottore sbarra la finestra da cui spiava gli altri con delle assi di legno: non c'è più nulla da guardare, non c'è un futuro cui volgersi. L'unica possibilità è tornare al principio e ricominciare: la commedia umana, che può essere ambientata nella pianura ungherese al termine del comunismo, ma forse anche in qualsiasi altro luogo, può proseguire, senza un vero principio e una vera conclusione, fino alla notte dei tempi.
22/08/2018
cast:
Éva Almássy Albert, János Derzsi, László feLugossy, Putyi Horváth, Mihály Vig
regia:
Béla Tarr
titolo originale:
Sátántangó
durata:
435'
sceneggiatura:
Béla Tarr
fotografia:
Gábor Medvigy
montaggio:
Ágnes Hranitzky
costumi:
János Breckl, Gyula Pauer
musiche:
Mihály Vig